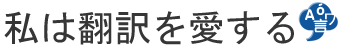- テキスト
- 歴史
Dall’antica significanza della voce
Dall’antica significanza della voce latina Cingulum: “ripiano sporgente sul versante di un monte” o, con esito pressoché analogo, “sporgenza rocciosa cingente in tutto o in parte un monte”.
L’origine di Cingoli, l’antica Cingulum dei Romani, è stata generalmente collegata al nome di Tito Labieno, luogotenente di Giulio Cesare in Gallia. Parlando della sua avanzata nel Piceno quest’ultimo menziona infatti Cingulum “quod oppidum labienus constituerat quaque pecunia exaedificaverat” e ricorda il contributo in uomini che essa aveva dato al suo partito nella guerra civile.
L’omogeneità del tessuto urbano corrisponde a una forte coesione ambientale: l’abitato, la cui salubrità climatica è proverbiale ormai da cinque secoli, si inserisce armonicamente in un paesaggio dove l’opera dell’uomo e quella della natura si sono perfettamente integrate valorizzandosi a vicenda.
L’antica varietà dei colori caldi degli intonachi delle facciate degli edifici, che si susseguono ininterrotammente lungo l’arteria principale della città o si ergono isolati in qualche suggestiva piccola via secondaria, armoniosamente intercalata dall’austerità della pietra degli eleganti portali rinascimentali emanano una sensazione di calma e rara atemporalità. Una suggestiva atmosfera rafforzata dalla chiusura del centro alla circolazione automobilistica nelle ore pomeridiane e serali.
Il visitatore, anche il più assorto, è subito rapito, in modo quasi discreto, da angoli e scorci di grande impatto scenico ed emotivo che Cingoli rivela durante le diverse ore del giorno.
L’origine di Cingoli, l’antica Cingulum dei Romani, è stata generalmente collegata al nome di Tito Labieno, luogotenente di Giulio Cesare in Gallia. Parlando della sua avanzata nel Piceno quest’ultimo menziona infatti Cingulum “quod oppidum labienus constituerat quaque pecunia exaedificaverat” e ricorda il contributo in uomini che essa aveva dato al suo partito nella guerra civile.
L’omogeneità del tessuto urbano corrisponde a una forte coesione ambientale: l’abitato, la cui salubrità climatica è proverbiale ormai da cinque secoli, si inserisce armonicamente in un paesaggio dove l’opera dell’uomo e quella della natura si sono perfettamente integrate valorizzandosi a vicenda.
L’antica varietà dei colori caldi degli intonachi delle facciate degli edifici, che si susseguono ininterrotammente lungo l’arteria principale della città o si ergono isolati in qualche suggestiva piccola via secondaria, armoniosamente intercalata dall’austerità della pietra degli eleganti portali rinascimentali emanano una sensazione di calma e rara atemporalità. Una suggestiva atmosfera rafforzata dalla chiusura del centro alla circolazione automobilistica nelle ore pomeridiane e serali.
Il visitatore, anche il più assorto, è subito rapito, in modo quasi discreto, da angoli e scorci di grande impatto scenico ed emotivo che Cingoli rivela durante le diverse ore del giorno.
0/5000
古代ラテン語の基底結節「山の全部または一部を岩の棚cingente。 "
曲の起源は、古代基底結節の、「棚が丘の側面に突出」または、ほぼ同様の結果との意義ローマンは一般ティトラビエヌス、ガウルジュリアス·シーザーの中尉の名前にリンクされています。後者では、彼の高度なピチェーノといえば、実際の基底結節」QUOD oppidumラビエヌスconstituerat Quaque金銭exaedificaverat」に言及し、内戦に彼の党にそれを与えていた男性の貢献を振り返ります。
都市構造の均一性が強いに対応環境結束:村、その健康な気候、過去5世紀にもわたってことわざですが、人間と自然の作品は完全にvalorizzandosi互いに統合されている風景に調和し合います。
メインininterrotammenteに沿って発生、建物のファサードの漆喰の暖色系、古代の様々いくつかの小さな絵の通りに孤立した都市やスタンド、エレガントなルネッサンスのポータルの石の調和散在緊縮は穏やかで、希少な永遠の感覚を発散。午後と夕方の間に自動車交通センターの閉鎖によって強化魅力的な雰囲気。
お客様は、も、最も吸収され、それは、ほとんど目立たない、すぐに誘拐された隅や角に大きな風光明媚な影響を、感情的なトラックから、一日の異なる時間帯にあることを明らかにしている。
曲の起源は、古代基底結節の、「棚が丘の側面に突出」または、ほぼ同様の結果との意義ローマンは一般ティトラビエヌス、ガウルジュリアス·シーザーの中尉の名前にリンクされています。後者では、彼の高度なピチェーノといえば、実際の基底結節」QUOD oppidumラビエヌスconstituerat Quaque金銭exaedificaverat」に言及し、内戦に彼の党にそれを与えていた男性の貢献を振り返ります。
都市構造の均一性が強いに対応環境結束:村、その健康な気候、過去5世紀にもわたってことわざですが、人間と自然の作品は完全にvalorizzandosi互いに統合されている風景に調和し合います。
メインininterrotammenteに沿って発生、建物のファサードの漆喰の暖色系、古代の様々いくつかの小さな絵の通りに孤立した都市やスタンド、エレガントなルネッサンスのポータルの石の調和散在緊縮は穏やかで、希少な永遠の感覚を発散。午後と夕方の間に自動車交通センターの閉鎖によって強化魅力的な雰囲気。
お客様は、も、最も吸収され、それは、ほとんど目立たない、すぐに誘拐された隅や角に大きな風光明媚な影響を、感情的なトラックから、一日の異なる時間帯にあることを明らかにしている。
翻訳されて、しばらくお待ちください..


ラテンの Cingulum 声の歴史的意義:「吊り棚山の側に」またはほぼ同様の結果"cingente 岩のオーバー ハングの全部または一部を".
Cingoli、ローマの古代の Cingulum の起源は一般的にタイタス Labienus、ガリアでカエサルの中尉の名に接続されています。この後者の事実彼の進歩のピチェーノで話す"quod oppidum labienus quaque constituerat pecunia exaedificaverat"の Cingulum の言及し、貢献をリコール男性を与えた市民戦争で彼の党に
都市のファブリックの均質性が強い環境結束: その気候上の健康は 5 世紀のことわざ、村風景に調和のとれた合うどこで統合が完全に自然と人間の作業古代都市やスタンドの主要な動脈に沿って ininterrotammente に従うの建物の温かみのある色調のファサード絆創膏各種いくつか魅力的な小さな通りで分離された
。調和のとれたエレガントな石の緊縮から入れ子になったルネサンス ポータル発散穏やか、まれな永遠の感じ。自動車交通の閉鎖によって強化されて挑発的な雰囲気センター午後および夕方時間。
、訪問者、さらにもっと夢中に、すぐに誘拐されほとんど控えめです偉大な風光明媚な感情的な見え隠れして角度からその日の異なる時間帯にトラックを明らかに影響を与えます。
Cingoli、ローマの古代の Cingulum の起源は一般的にタイタス Labienus、ガリアでカエサルの中尉の名に接続されています。この後者の事実彼の進歩のピチェーノで話す"quod oppidum labienus quaque constituerat pecunia exaedificaverat"の Cingulum の言及し、貢献をリコール男性を与えた市民戦争で彼の党に
都市のファブリックの均質性が強い環境結束: その気候上の健康は 5 世紀のことわざ、村風景に調和のとれた合うどこで統合が完全に自然と人間の作業古代都市やスタンドの主要な動脈に沿って ininterrotammente に従うの建物の温かみのある色調のファサード絆創膏各種いくつか魅力的な小さな通りで分離された
。調和のとれたエレガントな石の緊縮から入れ子になったルネサンス ポータル発散穏やか、まれな永遠の感じ。自動車交通の閉鎖によって強化されて挑発的な雰囲気センター午後および夕方時間。
、訪問者、さらにもっと夢中に、すぐに誘拐されほとんど控えめです偉大な風光明媚な感情的な見え隠れして角度からその日の異なる時間帯にトラックを明らかに影響を与えます。
翻訳されて、しばらくお待ちください..


他の言語
翻訳ツールのサポート: アイスランド語, アイルランド語, アゼルバイジャン語, アフリカーンス語, アムハラ語, アラビア語, アルバニア語, アルメニア語, イタリア語, イディッシュ語, イボ語, インドネシア語, ウイグル語, ウェールズ語, ウクライナ語, ウズベク語, ウルドゥ語, エストニア語, エスペラント語, オランダ語, オリヤ語, カザフ語, カタルーニャ語, カンナダ語, ガリシア語, キニヤルワンダ語, キルギス語, ギリシャ語, クメール語, クリンゴン, クルド語, クロアチア語, グジャラト語, コルシカ語, コーサ語, サモア語, ショナ語, シンド語, シンハラ語, ジャワ語, ジョージア(グルジア)語, スウェーデン語, スコットランド ゲール語, スペイン語, スロバキア語, スロベニア語, スワヒリ語, スンダ語, ズールー語, セブアノ語, セルビア語, ソト語, ソマリ語, タイ語, タガログ語, タジク語, タタール語, タミル語, チェコ語, チェワ語, テルグ語, デンマーク語, トルクメン語, トルコ語, ドイツ語, ネパール語, ノルウェー語, ハイチ語, ハウサ語, ハワイ語, ハンガリー語, バスク語, パシュト語, パンジャブ語, ヒンディー語, フィンランド語, フランス語, フリジア語, ブルガリア語, ヘブライ語, ベトナム語, ベラルーシ語, ベンガル語, ペルシャ語, ボスニア語, ポルトガル語, ポーランド語, マオリ語, マケドニア語, マラガシ語, マラヤーラム語, マラーティー語, マルタ語, マレー語, ミャンマー語, モンゴル語, モン語, ヨルバ語, ラオ語, ラテン語, ラトビア語, リトアニア語, ルクセンブルク語, ルーマニア語, ロシア語, 中国語, 日本語, 繁体字中国語, 英語, 言語を検出する, 韓国語, 言語翻訳.